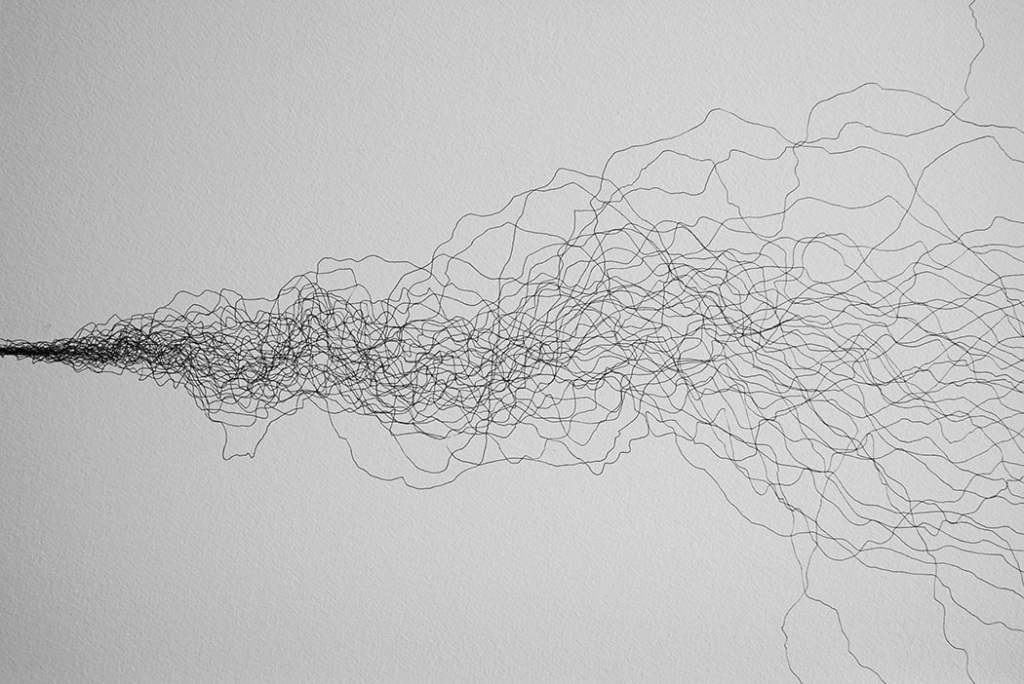ai miei allievi, con gratitudine…

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः
PATAÑJALI – yOGA SŪTRA i, 12
abhyāsa-vairāgyābhyāṁ tan-nirodhaḥ
la cessazione (delle fluttuazioni della mente) si ottiene attraverso la pratica costante e il distacco
La pratica dello yoga è essenzialmente una pratica individuale. Tradizionalmente l’insegnamento era trasmesso individualmente dal maestro e la pratica era solitaria. Oggigiorno nello yoga posturale contemporaneo l’insegnamento di gruppo ha sostituito quasi completamente quello individuale ma per un corretto apprendimento delle tecniche trasmesse e per comprendere quale risultato producano sulla nostra persona è necessario dedicarsi ad una pratica quotidiana (o quasi quotidiana), in solitudine, perché è indispensabile sviluppare una capacità di ascolto e di osservazione indipendente, che si emancipi dalla guida dall’insegnante nel contesto protetto della classe.
Una prima esplicita indicazione tecnica sull’importanza della pratica costante nello yoga si trova nel Pātañjalayogaśāstra: in Y.S. I,12 Patañjali indica nella pratica (abhyāsa) e nel distacco (vairāgya) lo strumento per raggiungere il nirodhaḥ, l’obiettivo dello yoga1. Il termine abhyāsa indica un’azione ripetuta a lungo, con continuità e disciplina e vairāgya indica un atteggiamento mentale di distacco, di “distanza” da ciò che si fa. Questo sūtra e la funzione della pratica e del distacco nel controllo della mente è anticipato nella Bhagavadgītā in 6.35
śrī-bhagavān uvāca
asaṁśayaṁ mahā-bāho
mano durnigrahaṁ calam
abhyāsena tu kaunteya
vairāgyeṇa ca gṛhyate
śrī-bhagavān (Kṛṣṇa) disse:
senza dubbio o potentemente armato
la mente (è) mobile e difficile da frenare
ma, oh figlio di Kuntī, con la pratica
e col distacco può essere controllata2
L’importanza della costanza nella pratica è sostanziale: in Y.S. I,13 la pratica diventa stabile grazie allo sforzo, alla fatica (yatna) che si protrae con costanza, senza interruzione (nairantarya), per molto tempo (dīrghakāla) con un atteggiamento di reverenza e rispetto (satkāra) (Y.S. I,14).
Il distacco consiste in quella speciale padronanza di sé in cui non si è più dominati dai desideri (Y.S. I,15). Queste indicazioni si riferiscono in modo specifico alla pratica del nirodha, riguardano cioè la pratica avanzata di controllo delle fluttuazioni mentali, ma possiamo estenderle ad ogni aspetto tecnico dello yoga.
Patañjali dedica esplicitamente il secondo capitolo, il Sādhana pāda, alla pratica.: il termine sādhana indica un metodo, una disciplina per raggiungere uno specifico obiettivo. Questo capitolo si apre con la descrizione del kriyāyoga che fornisce le discipline pratiche necessarie al conseguimento dei successivi otto aṅga dell’aṣṭāṅgayoga: tapas (l’austerità), svādhyāya (la riflessione sul sé) ed iśvarapraṇidhāna (l’abbandono ad Iśvara) e, potremo dire, ricordano al praticante l’atteggiamento da conservare durante ogni tipo di pratica: il rigore, lo sforzo3; l’osservazione delle proprie dinamiche, di ciò che gli accade e l’abbandono fiducioso al Signore o, secondo una lettura più laica, l’abbandono fiducioso a qualcosa che ci trascende e che, comunque vada, continuerà a reggere l’Universo. Questi tre elementi saranno poi ripresi nel secondo aṅga riguardante i niyama, le regole di condotta personale.
Essenzialmente, Patañjali indica la necessità di una pratica condotta con uno sforzo, che richiede cioè una certa fatica e dedizione, eseguita con costanza e per molto tempo. Ogni schema, ogni condizionamento richiede un lavoro per essere visto, compreso e decostruito, Una pratica come quella dello yoga nella sua più profonda essenza aspira non solo a conoscere ma a trasformare la nostra condizione sino a condurci alla liberazione e produce frutti se ci si dedica con costanza. In ogni caso, una pratica occasionale è sicuramente utile, perché ci fa intravedere possibilità di solito ignorate e ci pone in ascolto di noi stessi,
In alcuni testi ritroviamo anche indicazioni specifiche che riguardano il luogo della pratica, le ore in cui è proficuo praticare, indicazioni riguardanti la dieta ed altri accorgimenti utili. Vado di seguito a riassumerle riferendomi ai testi più conosciuti.
Del Luogo
Lo “spazio” è più astratto del “luogo” Ciò che inizia come uno spazio indifferenziato diventa un luogo man mano che lo conosciamo meglio e gli attribuiamo un valore.
YI-FU TUAN
Nello Yoga Yajñavalkya Saṃhitā, un testo databile tra il XII ed il XIV secolo, dopo aver ricevuto gli insegnamenti dal saggio Yājñavalkya, Gārgī si ritira in isolamento nella foresta per praticare gli insegnamenti ricevuti:
Yogaṁ susaṅgṛhya tadā rahasye, rahasyajaṁ muktikaram ca antaḥ
saṁsāram utsṛjya sadā mudānvitā, vane rahasyāvasathe viveśa
allora, avendo ben assimilato lo Yoga segreto, che dona la liberazione, in privato,
(Gārgī) abbandonato il samsāra, colma di gioia entrò nella dimora segreta nella foresta4
In un testo del XIII secolo, il Dattātreyayogaśāstra, troviamo le indicazioni relative al luogo dove praticare il prāṇāyāma:
prāṇāyāmaṃ tataḥ kuryāt padmāsanagataḥ sadā
suśobhanaṃ maṭhaṃ kuryāt sūkṣmadvāraṃ tu nirvraṇam
suṣṭhu liptaṃ gomayena sudhayā vā prayatnataḥ
matkuṇair maśakair lūtair varjitaṃ ca prayatnataḥ
dine dine susaṃmṛṣṭaṃ saṃmārjanyāpy atandritaḥ
vāsitaṃ ca sugandhena dhūpitaṃ guggulādibhiḥ
malamūtrādibhir vargair aṣṭādaśabhir eva ca
varjitaṃ dvārasampannaṃ vastrāvaraṇam eva vā
nātyunnataṃ nātinīcaṃ parasaṃgavivarjitam
tasmin maṭhe samāstīrya āsanaṃ nistaraṅgakam
tatropaviśya medhāvī padmāsanasamanvitaḥ
ṛjukāyaḥ prāñjaliś ca praṇamed iṣṭadevatām
allora dovrebbe praticare regolarmente il controllo del respiro mentre è seduto nella posizione del loto.
dovrebbe costruire una bella capanna con una piccola apertura e senza fessure,
rivestita con cura e spesso di sterco di mucca o calce,
accuratamente ripulita da cimici, zanzare e insetti,
e pulita ogni giorno con diligenza, instancabilmente
profumata con fragranze fini e fumigata con il fumo di sostanze come il bdellio.
libera dai diciotto tipi [di impurità] come feci, urina e così via
dotata di una porta o chiusa solo con un panno
non troppo alta né troppo bassa, e lontana dalla compagnia di altre persone.
In un tale eremo, dopo aver steso una stuoia senza pieghe,
sedutosi su di esso nella posizione del loto.
Con il corpo eretto, il saggio dovrebbe unire le mani e adorare la divinità prescelta5
Queste indicazioni saranno poi riprese nel più conosciuto testo dello Haṭhayoga, l’Haṭhayogapradīpikā (XV secolo) ed in questo testo si riferiscono al luogo dove praticare lo yoga in generale:
surājye dhārmike deśe subhikṣe nirupadrave
ekāntamaṭhikāmadhye sthātavyaṃ haṭhayoginā
alpadvāram arandhragartapiṭharaṃ nīcāyatam
samyaggomayasāndraliptam amalaṃ niḥśeṣabādhojjhitam
bāhye maṇḍapavedikūparuciraṃ prākārasaṃveṣṭitaṃ
proktaṃ yogamaṭhasya lakṣaṇam idaṃ siddhair haṭhābhyāsibhiḥ
evaṃvidhe maṭhe sthitvā sarvacintāvivarjitaḥ
gurūpadiṣṭamārgeṇa yogam eva samabhyaset
in una regione ben governata, giusta, con abbondanza di cibo e
libera da sconvolgimenti, l’Haṭhayogi dovrebbe vivere in una capanna isolata
(che) ha una piccola porta ed è priva di crepe, buchi e protuberanze.
non è né troppo alta né troppo bassa ed è cosparsa di sterco di mucca, come si deve.
è pulita, libera da qualsiasi fastidio, gradevole all’esterno,
con veranda, altare e pozzo, circondata da un muro:
queste sono le caratteristiche della capanna yoga,
così come insegnata dai praticanti esperti di Haṭha.6
Nella Gheraṇḍa Saṃhitā, testo Haṭhayoga del XVI secolo, viene fornita la descrizione del luogo adatto per la pratica del prāṇāyāma:
dūradeśe tathāraṇye rājadhānyāṃ janāntike
yogarambhaṃ na kurvīta kṛtaniścat siddhihā bhavet
aviśvāsaṃ dūradeśe araṇye rakṣivivirjitam
lokāraṇye prakāśca tasmāt trīṇi vivirjayet
sudeśe dhārmike rājye subhikṣe nirupadrave
tatraikaṃ kuṭīraṃ kṛtvā prācīraiḥ pariveṣṭitam
lāpīkūpataḍāgaṃ ca pracīra madhyavarti ca
tātyuccaṃ nātinīcaṃ kuṭīraṃ kīṭavarjitam
samyaggomayā liptaṃ ca kuṭīraṃ tatranirmitam
evaṃ sthāneṣu gupteṣu prāṇāyāmaṃ samabhyaset
Non si dovrebbe iniziare lo Yoga in una zona remota, in una foresta, in una città o vicino alle persone.
Se intrapresa in questi luoghi, la pratica lo Yoga non ha successo.
In una zona remota non c’è sicurezza, in una foresta non c’è cibo e tra le persone
c’è il bagliore della pubblicità, quindi evita queste tre
In un regno buono e devoto, dove le elemosine sono facilmente reperibili e dove non ci sono sconvolgimenti, costruisci una capanna e circondala con un muro.
Dovrebbe esserci un serbatoio, un pozzo o uno stagno nel complesso e la capanna non dovrebbe essere né troppo alta né troppo bassa e libera da insetti
la capanna dovrebbe essere adeguatamente ricoperta di sterco di mucca e priva di buchi.
Solo in un luogo appartato come questo si dovrebbe praticare il prāṇāyāma7
È interessante notare come il luogo adatto alla pratica cambi col tempo: alla foresta, luogo del ritiro dell’asceta rinunciante si preferiscono luoghi via via più confortevoli, capaci di garantire una tranquillità al praticante, si sottolinea la necessità di praticare in un contesto politico e sociale tranquillo, dove ci sia la possibilità di procurarsi del cibo e dell’acqua, lontani dalle persone ma non così isolati da sentirsi in pericolo. Lo spazio per la pratica è discreto, sufficiente, non troppo ampio, né troppo angusto, pulito, libero da insetti che possono recare fastidio ed impedire un’adeguata concentrazione.
Del tempo
Chi ha tempo non aspetti tempo
PROVERBIO ITALIANO
I testi danno indicazioni relative al periodo dell’anno e alle ore del giorno in cui è meglio praticare. Generalmente queste indicazioni riguardano in modo più specifico il prāṇāyāma e individuano, per esempio, i momenti della giornata più idonei ad ogni specifica tecnica: nell’Haṭhayogapradīpikā, ad esempio si indica come
prātar madhyandine sāyam ardharātre ca kumbhakān
śanair aśītiparyantaṃ caturvāraṃ samabhyaset
(lo yogi) dovrebbe praticare delicatamente ritenzioni (kumbhaka) quattro volte,
all’alba, a mezzogiorno, al tramonto e a mezzanotte, per un totale di ottanta.8
o ancora nello Yoga Yajñavalkya Saṃhitā la tecnica di nāḍīśōdhana deve essere praticata come indicato:
tricaturvatsaraṁ vātha tricatūrṇaṁ samaṁ eva vā
ṣaṭkṛtvā ācaret nityaṁ rahasyeva trisandhiṣu
per tre o quattro anni o tre o quattro mesi egli dovrebbe praticare
per sei volte, in un luogo solitario, nei tre momenti di transizione del giorno9
Nella Gheraṇḍa Saṃhitā si sconsiglia di iniziare la pratica del prāṇāyāma nelle stagioni estreme, quando fa troppo caldo o troppo freddo e nella stagione delle piogge.
Igiene, regole di comportamento e dieta
Le strade della libertà sono strette e disciplinate.
G. L. FERRETTI
Nella Bhagavadgītā Kṛṣṇa afferma:
nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna
yuktāhāra-vihārasya
yukta-ceṣṭasya karmasu
yukta-svapnāvabodhasya
yogo bhavati duḥkha-hā
lo yoga non è possibile per chi mangia troppo
e nemmeno per colui che digiuna
né per colui che dorme troppo
e nemmeno per colui che veglia, o Arjuna
per colui che ha alimentazione e svago moderato
che è moderato nel compiere i doveri
che è moderato nel sonno e nella veglia
(per lui) lo yoga diventa il distruttore della sofferenza10
Il primo ed il secondo aṅga dell’aṣṭāṅgayoga di Patañjali indicano le regole che il praticante deve osservare socialmente e nei riguardi della propria persona: in l’ambito sociale, il comportamento del praticante deve modularsi sui principi di non violenza (ahiṁsā), veridicità (satya), astensione dal furto (asteya), astinenza (o morigeratezza) sessuale (brahmacarya) e non attaccamento alle cose (aparigrahāḥ); riguardo la propria persona, lo yogi deve coltivare la pulizia esteriore ed interiore (śauca), l’accettazione delle circostanze per come sono (saṁtoṣa), l’austerità e l’autodisciplina ( tapas), lo studio di sé e dei testi (svādhyāya) e l’abbandono praticato al Signore (iśvarapraṇidhāna).
Nel primo capitolo dell’Haṭhayogapradīpikā11 ci sono indicazioni precise sul comportamento che lo yogi deve mantenere: egli deve attenersi ad una condotta sessuale controllata, nutrirsi non troppo, né troppo poco con cibo sattvico, evitare certi cibi, certi luoghi e certe frequentazioni. L’Haṭhayogapradīpikā è un’antologia di testi e queste indicazioni sono presenti in fonti testuali precedenti, come la Gorakṣaśataka (XIV secolo) e la Vivekamārtaṇḍa (XIII secolo)
Suggerimenti per una pratica nel nostro tempo
If you fall, I’ll be there!
YOUR YOGA MAT
Ho voluto accennare alle indicazioni riportate solo nei testi più conosciuti, sebbene ulteriori indicazioni si trovino anche in altri testi, Come possiamo integrare queste indicazioni nel nostro tempo? Quali sono oggigiorno gli elementi da tenere presenti per riuscire ad instaurare una pratica continuativa? Viviamo un epoca di grande confusione, gli stimoli e le sollecitazioni a cui siamo costantemente sottoposti rendono la nostra mente particolarmente indisciplinata e confusa; il ritmo della vita, le abitudini, i comportamenti alimentari e sociali contribuiscono a rendere difficile l’instaurarsi di una prassi. Questi fattori vanno considerati nella dovuta misura: è cioè comprensibile che rendano difficile essere costanti nella pratica, ma occorre riconoscere che nulla si ottiene gratuitamente e dobbiamo considerare la necessità dello sforzo e della rinuncia, rivalutare il ruolo del sacrificio. Di pari passo, è necessario mantenere una certa pietas, un atteggiamento amorevole verso la nostra inadeguatezza e le nostre difficoltà. Non è facile dosare il rigore, evitando che si traduca in fanatismo e rigidità ed evitare che la compassione diventi lassismo e pigrizia.
Se guardiamo ai testi, a me pare che le indicazioni fornite siano funzionali ad instaurare una certa tranquillità d’animo, indispensabile per intraprendere un percorso spirituale sincero, si tratta cioè di indicazioni tecniche, non morali ma strumentali. A partire da queste indicazioni, ma scendendo a patti con la realtà del nostro tempo, voglio qui dare dei suggerimenti, provando a schematizzarli in un elenco. Potete iniziare da ciò che sentite più “fattibile”, in sintonia con la vostra persona ed il momento che state vivendo. Cercate di consolidare un punto alla volta, integrando pian piano ciò che ritenete utile: un giorno di pratica è infinitamente più significativo di nessun giorno di pratica ed ogni giorno in più è un ulteriore passo conquistato. Considerate l’intera giornata come un’opportunità per praticare: la condotta sociale, personale, la dieta e l’igiene sono strumenti che possiamo praticare costantemente e che, una volta padroneggiati, trasformeranno la nostra pratica di yoga sul tappetino.
Prendete tutte queste indicazioni come fossero un gioco dove nessuno perde, nessuno vince ma si rischia di divertirsi parecchio e di conoscersi un po’ di più.
❂ Mantenete una condotta sociale rispettosa dell’altro, di ciò che vi circonda, di ogni creatura senziente e non senziente (le pietre, per me, sono creature…). Imparate a fare un passo indietro quando il conflitto è superfluo e a stare saldi quando occorre prendere una posizione. Osservatevi: per chi lo fate? Cosa vi anima quando agite?
❂ Nutritevi in modo semplice, preferite una dieta vegetariana o semi vegetariana, integrale, naturale. Imparate a distinguere il “nutrirsi” dal “mangiare”.
❂ Prendete la giusta distanza dagli affetti.
❂ Passate del tempo in mezzo alla natura, nei boschi, Camminate scalzi quando potete, fate bagni di sole e d’acqua nudi, riappropriatevi specialmente del senso del tatto.
❂ Coltivate una igiene nelle frequentazioni, filtrate ciò che guardate, leggete ed ascoltate. Evitate di lasciare TV accesa o la musica in sottofondo se non le prestate la dovuta attenzione. Nutrite la vostra mente in modo adeguato, evitando ciò che la rende agitata, irrequieta (osservatevi!). Concedetevi dei momenti in cui stare in silenzio.
❂ Cercate di stabilire il luogo della vostra pratica in un posto tranquillo, lontano dai rumori e preferibilmente al chiuso. Calcolate attorno al tappetino uno spazio minimo che vi consenta di potervi muovere senza dover spostare gli oggetti attorno a voi mentre praticate. Assicuratevi di avere a portata di mano cuscini, corde, mattoncini e gli ausili di cui potreste aver bisogno durante la pratica. Se non disponete di uno spazio privato, avvertite i famigliari di non disturbarvi durante la pratica (è un esercizio di assertività!) o scegliete un orario in cui riuscite ad essere soli. Consacrate lo spazio prima di iniziare, anche semplicemente ringraziando i Maestri o recitando qualcosa che “segni” l’inizio della vostra pratica.
❂ Potete stabilire un orario per praticare o praticare in momenti diversi della giornata. A parer mio entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi: l’orario fisso vi aiuta a costruire un’abitudine, ma non è sempre rispettabile; cambiare orario può essere di disturbo, ma vi da l’opportunità di osservare come rispondete alla pratica a seconda del momento della giornata. Sperimentate, variate, l’importante è praticare.
❂ La pratica va fatta a digiuno ed è opportuno aspettare una mezz’ora dopo aver praticato prima di fare un pasto completo. Non fatevi la doccia subito dopo la pratica, lasciate passare almeno una mezz’ora.
❂ Ascoltatevi prima di praticare e scegliete il tipo di pratica che meglio si adatta alla vostra condizione, al tempo che avete a disposizione e considerate sempre cosa dovete fare dopo: non è opportuno, per esempio, dedicarsi ad una pratica eccessivamente interiorizzante se poi dobbiamo andare al lavoro. Diminuite il numero di ripetizioni se non avete sufficiente tempo, privilegiate sempre la qualità di ciò che fate alla quantità.
❂ Non si può praticare se siamo in una condizione di grande disturbo emotivo o mentale: prendetevi del tempo per uscire, vedere un amico o fare qualsiasi cosa vi consenta di ristabilire un certo equilibrio. Potete eventualmente dedicarvi ad una pratica dinamica, senza forzare sull’attenzione. Evitate assolutamente il prāṇāyāma.
❂ Affrontate il prāṇāyāma solo quando la pratica di āsana è abbastanza consolidata e procedete per gradi. Le ritenzioni del respiro vanno inserite solo quando i ritmi del respiro sono agevoli e consolidati.
❂ Non irrigiditevi se non riuscite a rispettare i programmi: la vita non si può controllare e la flessibilità richiesta nella pratica è innanzitutto mentale. Lasciar andare (vairāgya) è una pratica.
❂ Provate ad integrare i principi dello yoga posturale nella vostra vita, allenate la flessibilità, la forza, l’ascolto, l’attenzione in ogni istante e nelle circostanze più disparate.
❂ Tenete nota di tutto ciò che vi accade durante e dopo la pratica, annotate difficoltà, dubbi, risultati, successi e fallimenti, parlatene con il vostro insegnante e non abbiate mai il timore di chiedere delucidazioni o spiegazioni: non sempre vi verranno fornite, ma questa è un’altra storia…
- Vorrei sottolineare come l’obiettivo dello yoga in qualsiasi tradizione è il raggiungimento di uno stato che trascende la dimensione soggettiva, individuale. Non è questo il contesto in cui approfondire questo elemento, ma è importante tenerlo a mente per comprendere questa discipliche che altrimenti si riduce ad una semplice attività psico-fisica. ↩︎
- Traduzione mia ↩︎
- Tapas indica precisamente lo sforzo che domina i sensi e produce calore. ↩︎
- Yoga Yajñavalkya Saṃhitā XII, 44 ↩︎
- Dattātreyayogaśāstra 54-59 ↩︎
- Haṭhayogapradīpikā I, 12–14 ↩︎
- Gheraṇḍa Saṃhitā V, 3-7 ↩︎
- Haṭhayogapradīpikā II, 11 ↩︎
- Yoga Yajñavalkya Saṃhitā V, 20 ↩︎
- Bhagavadgītā VI, 16-17 ↩︎
- Haṭhayogapradīpikā I, 57-63 ↩︎