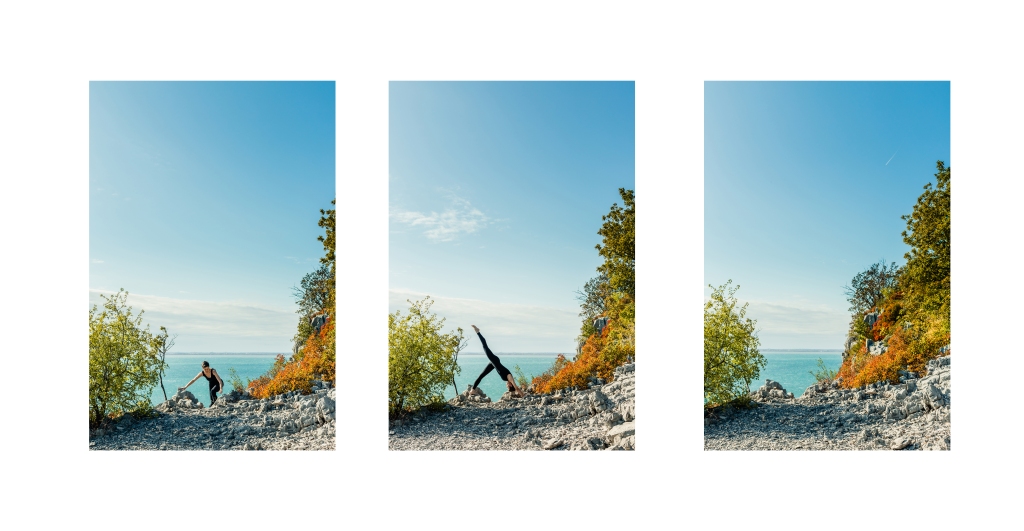La disturbante evidenza dei giorni perfetti…

Un guscio
MATSUO BASHŌ
di cicala, svuotarsi
nel canto
Vado di rado al cinema. Da giovane era un appuntamento fisso la domenica pomeriggio, il cinema d’essai, quello alternativo, quello dei grandi registi, spesso incomprensibile, che ti lasciava tracce indelebili e richiedeva giorni di decantazione e riflessione per essere assimilato, digerito. Un cinema pedagogico, che richiedeva uno sforzo e che poco aveva a che fare con lo svago. Quel cinema mi ha nutrita e cresciuta, ha contribuito a formare il mio gusto estetico, ha affinato la mia sensibilità, ingentilito la mia attitudine all’ascolto e mi ha resa curiosa verso ciò che non è immediatamente comprensibile, verso ciò che richiede tempo e sacrificio per essere in parte assimilato.
Poi più nulla.
“Perfect Days”, l’ultimo film di Wim Wenders mi ha sorpresa. Un film fatto di una storia semplice, la storia di Hirayama, un uomo silenzioso che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo e che trascorre con cura le sue giornate apparentemente sempre identiche, scandite da gesti che si ripetono, come fossero rituali religiosi, gesti piccoli, piccole passioni, piccoli momenti di svago, piccole relazioni. Cose minute, fatte di sfumature, di attimi colti dalla sua macchina fotografica o celebrati dalla musica che ascolta su cassette analogiche mentre va al lavoro. Il film ha una struttura narrativa che è difficile riassumere, perché è lieve, banale e Wenders solo accenna alla storia del personaggio: le sue letture assidue (la libraia dove acquista abitualmente i libri lo chiama “intellettuale”, lui nega e sorride), la facoltosa e benestante famiglia di origine, un padre a cui Hirayama non rivolge da tempo la parola, suggeriscono allo spettatore che qualcosa sia accaduto e che Hirayama abbia “scelto” quella vita o che a quella vita si sia consapevolmente adattato. Hirayama non è sempre felice, anzi, non è mai felice. Guarda al mondo per com’è, senza alcuna ingenuità, non pretende che sia diverso e nell’assenza di ogni pretesa trova pace, trova un piccolo spazio interiore di silenzio e sorride. Un sorriso che nella scena finale, (spettacolare, grandissima e che da sola vale la Palma d’Oro a Cannes per l’attore protagonista) diventa melanconico, sofferto, triste ma rimane la sola risposta sensata al mistero della vita.
Questo sorriso rimane l’elemento profondamente disturbante del film. Non è vero, come ha dichiarato il regista, che “Ci basta meno di quanto abbiamo, l’importante è gioire di ogni cosa”, no. L’importante è sorridere, conservare il riso sotto ogni cosa, sia essa gioita o sofferta, sia essa scelta o subita. È accettare il dharma, la rinuncia, la sottomissione consapevole alla vita, al suo fluire, al suo mistero.
Wenders ha partorito una creatura sorprendente, talmente viva che gli è sfuggita di mano, a mio parere e che ci ha sbattuto in faccia una inquietante verità: la vita non va edulcorata, cambiata, significata, va vissuta. E no, nessuno invidia Hirayama, la sua vita, il suo lavoro come addetto alle pulizie: quello che lo spettatore (e forse Wim) inconsapevolmente invidia è la capacità che il protagonista ha di vivere la sua propria vita, ogni istante, regalando a quella vita apparentemente banale una pienezza, una consistenza di cui le nostre vite sono prive. Lui vive, noi trascorriamo il tempo, chi a guardare il film, chi a farlo.
Se le dichiarazioni del regista sul suo proprio film mi hanno lasciata perplessa, tanto da domandarmi se poi, una volta finito, lo avesse visto il suo film, una certa critica intellettuale progressista, lo confesso, mi ha fatto incazzare.
Lorenzo Grammatica in un articolo su http://www.lucysullacultura.it accusa il film di essere retorico, che la vita è sofferenza, caos, disordine, altro che gioire delle piccole cose e che il protagonista ha ben poco da ridere, considerato il lavoro di merda che fa (pulire i cessi per una certa parte della società civile è evidentemente un lavoro degradante e privo di dignità, infatti si chiede se lo abbia scelto: chi sceglierebbe un lavoro del genere? È roba da reietti) e la misera vita che conduce, priva di moglie, figli, affetti (non ha nemmeno un animale da compagnia, sottolinea). Insomma, per Grammatica c’è poco da ridere, che una vita “senza” non è una vita, il protagonista, in fondo, è uno senza palle, senza ambizioni ed il film piace, perché o siamo sfigati come lui o confondiamo la sua pochezza umana (eh, se non hai ambizioni, non vuoi un lavoro migliore, non competi in amore, non hai una moglie, affetti stabili e, per Dio, nemmeno un cane, insomma, non sei nessuno) per umiltà.
Questa visione disumanizzante, che considera meritevole di senso solo una vita “piena” e, badate, piena di cose il cui valore è dato per assoluto (come il lavoro, – solo un certo tipo di lavoro: ribadiamo, pulire i cessi è degradante – la famiglia, le relazioni, il desiderio di migliorare la propria condizione sociale) è profondamente materialistica e nega la validità di ogni altro approccio alla propria vita. Non solo: giudica come pericolosa ogni riflessione indipendente sul senso del proprio vivere e non ammette che si possa scegliere diversamente, non ammette la possibilità che la vita abbia comunque un senso, una densità, un valore di per sé, e che questo valore non dipenda da fattori esterni.
Il film di Wenders è potente, perché fa presagire la disturbante evidenza dei giorni perfetti, perfetti perché concessi, perché vissuti e non solo trascorsi. Ci fa intuire che si, c’è in fondo una possibilità per riuscire a sorridere in un mondo delirante, assurdo, crudele, faticoso ed è in mano nostra, anzi, è nel nostro sguardo, nella capacità che abbiamo (tutti) di guardare con occhi diversi una realtà che è quello che è e di viverla, nonostante tutto, viverla.