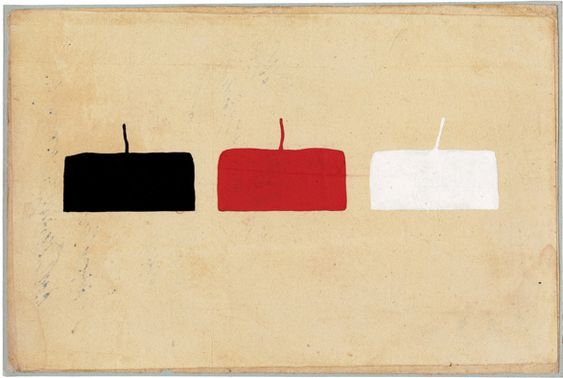
Ma se non crederete, non avrete stabilità.
libro di isaia
Partiamo dall’etimo. L’origine di una parola ne svela il significato, la rende carne da digerire ed assimilare. Credere viene dal latino crēdo, dal proto-italico krezdō, discendente del proto-indoeuropeo ḱred dheh, a sua volta composto di ḱḗr, “cuore”, stessa radice del latino cor e dheh, “mettere, stabilire”: dunque il significato di “mettere il cuore in”, riporlo altrove, fuori da sé, in qualcosa d’altro.
Il luogo del cuore si rivela carico di significati simbolici in ogni cultura, così nell’Antico Testamento troviamo descritto il cuore come l’organo che ci è stato donato per comprendere:
“Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro perché ragionassero. Li riempì di dottrina e d’intelligenza, e indicò loro anche il bene e il male. Pose lo sguardo nei loro cuori per mostrar loro la grandezza delle sue opere.”
Siracide 17, 5 – 7
Luogo dei sentimenti, dell’amore, nell’Islam custodisce rūḥ, il sé immortale dell’individuo ed è il luogo ove si intona lo dikhr, il ricordo di Allah, nel Sufismo.
Ancora, in Patanjali è con il saṃyama (la concentrazione) sul cuore che nasce la conoscenza della mente (Y.S. III, 34) e nello Sārdhatriśatikālottaratantra, uno dei primi testi tantrici śaiva a menzionare la Kuṇḑalinī, questa viene descritta come una spirale primordiale che risiede nel cuore.
Ma torniamo al credere. C’è un termine sanscrito che gli corrisponde ed è Śrāddha, una parola composta da śrat che in unione con la radice dhā, mettere, porre conserva il significato di “cuore” e ricalca il significato del latino crēdo a significare dunque il porre il proprio cuore in qualcosa, avere fiducia.
In Patanjali, l’atto di abbandono fiducioso al Signore è descritto dal termine praṇidhāna. Questa parola conserva la radice verbale dhā che nel verbo praṇidhā assume il significato di porre di fronte, depositare, rivolgere lo sguardo finanche mandare come emissario.
L’atto del credere sembra dunque implicare due gesti: l’espropriazione di una parte di sé, la parte fondamentale ed il riporla fuori da sé, in qualcos’altro. Il gesto è rivoluzionario, perché scardina l’integrità dell’individuo, eppure è parziale quando viene interpellata la ragione a comprendere e dare il beneplacito. Il credere deve essere fanatico, ossia in relazione col termine arabo fanā, presupporre cioè l’annichilamento, la distruzione di ogni pretesa di sicurezza e conferma e deve implicare uno “stare fuori” dagli schemi del cogito, un ex-sistĕre. L’esistere, dunque, pare quasi etimologicamente e, mi piace supporre, metafisicamente associato al credere come se il mistero del primo si possa risolvere solo nel gesto del secondo.
Tommaso, uno dei dodici, detto il gemello, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli gli dissero: “Abbiamo veduto il Signore”. Ma egli rispose: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò”. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne di nuovo, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi”. Poi si rivolse a Tommaso: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credi”. Rispose Tommaso: “Signore mio e Dio mio!” E Gesù gli disse: “Tu hai creduto perché mi hai veduto. Beati quelli che hanno creduto senza aver veduto”.
Giovanni 20, 24 – 29
Lo stato di beatitudine viene dal credere senza aver visto. La parola “beati” nell’originale testo in greco, μακάριος, denota coloro i quali hanno ricevuto la grazia dal Signore e (per questo) sono invidiati. Nel passo evangelico, che trovo tremendamente potente, il credere è un atto di resa, un’obbedienza ad un “altro” invisibile che ci feconda e ci grazia con la fede stessa, perché nulla viene dall’individuo se non la resa ed ogni gesto soggettivo non è che illusione, vanità.
E ancora, ricordo il passo evangelico dell’annunciazione del Signore e come all’iniziale atteggiamento stupido di Maria che resta incredula, perché ancora vergine, incapace di far ex-sistĕre il Figlio dell’Uomo, segua il credo e la resa che la rende feconda.
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto»
Luca, 1 – 38
È nel credere che esisto.




